Quando si parla di diritti reali come l’usufrutto, il confine tra proprietà e responsabilità fiscali e civili può diventare complesso. Le norme italiane stabiliscono con precisione chi deve pagare imposte e tributi, ma spesso i dubbi restano. Tra mutui, affitti e tasse locali, i rischi possono ricadere in modi inattesi.
Il rapporto tra nudo proprietario e titolare dell’usufrutto è regolato in modo chiaro dal codice civile e dalle leggi tributarie, ma nella pratica la gestione di un immobile può generare domande difficili. Chi paga l’IMU? Chi è tenuto alla TARI? E cosa accade se l’usufruttuario non adempie ai propri obblighi? A questi interrogativi si aggiunge la questione delle responsabilità civili e penali che possono derivare da affitti o da attività collegate all’immobile. Non va dimenticato che la stipula di un atto di usufrutto deve avvenire davanti a un notaio per avere efficacia verso i terzi, e che le obbligazioni si distribuiscono diversamente tra chi detiene il diritto di proprietà e chi esercita l’usufrutto.

In questo scenario, spesso la famiglia diventa protagonista: un genitore che utilizza la casa del figlio, affitti parziali concessi per integrare il reddito, utenze e tributi che si accumulano nel tempo. Le fonti normative come l’art. 26 del DPR 917/86 o la legge 160/2019 aiutano a chiarire il quadro, ma l’applicazione concreta suscita sempre nuove riflessioni. Un contesto che richiede attenzione e conoscenza delle regole, per non confondere doveri e diritti.
Usufrutto e obblighi fiscali
In base alla normativa italiana, l’usufruttuario è il soggetto tenuto al pagamento di imposte fondamentali sull’immobile. L’art. 26 del DPR 917/86 e l’art. 1 comma 743 della legge 160/2019 stabiliscono che l’IRPEF e l’IMU spettano interamente a chi gode del diritto di usufrutto, anche quando l’immobile viene concesso in affitto a terzi. La situazione è diversa per la TARI: secondo l’art. 1 commi 642-644 della legge 147/2013, il tributo sui rifiuti urbani è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali. Ciò significa che, se l’immobile è utilizzato dall’usufruttuario, sarà lui a dover pagare, ma in presenza di più soggetti la legge prevede la responsabilità solidale.
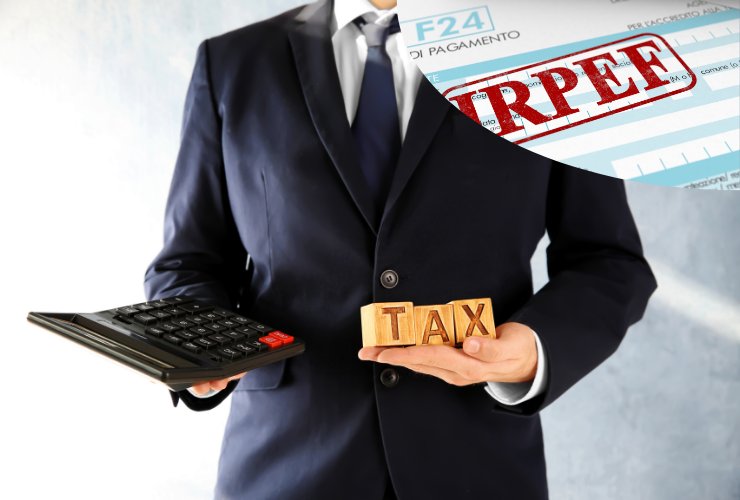
Gli esperti del Consiglio Nazionale del Notariato precisano che il nudo proprietario non ha obblighi diretti verso l’amministrazione finanziaria per IMU e IRPEF durante la durata dell’usufrutto. Tuttavia, può essere coinvolto indirettamente se l’immobile subisce pignoramenti o se i debiti dell’usufruttuario portano a procedimenti esecutivi. Per questo motivo la distinzione tra proprietà e diritto di godimento assume un peso rilevante nella pianificazione patrimoniale.
Responsabilità civili e gestione pratica
Accanto alle imposte, esistono altre forme di responsabilità che gravano sull’usufruttuario. Secondo il codice civile (artt. 1004 e seguenti), chi gode dell’immobile deve provvedere alle spese ordinarie, alle bollette e alla manutenzione ordinaria. Eventuali danni a terzi derivanti dall’uso dell’immobile o da affitti concessi dall’usufruttuario ricadono su di lui, così come le relative conseguenze civili o penali.
Il nudo proprietario, invece, resta titolare della sostanza del bene e deve affrontare le spese straordinarie, come quelle per ristrutturazioni importanti o rifacimenti strutturali. Fonti come l’Agenzia delle Entrate chiariscono che eventuali canoni di locazione percepiti dall’usufruttuario devono essere dichiarati da quest’ultimo ai fini fiscali, mentre il proprietario non è coinvolto. Tuttavia, la Cassazione in più sentenze (ad esempio n. 12265/2019) ha ribadito che il nudo proprietario non è automaticamente protetto da azioni esecutive sui beni se il debito fiscale colpisce l’usufruttuario: la tutela dipende da come è strutturato l’atto di concessione e dalla registrazione nei pubblici registri.
Questo significa che, pur non essendo obbligato a pagare IMU o IRPEF, il proprietario deve considerare i riflessi patrimoniali di un usufrutto inadempiente. Alcuni notai suggeriscono, in questi casi, di ricorrere a clausole specifiche nell’atto di usufrutto per limitare i rischi, prevedendo garanzie o fideiussioni. Una soluzione che permette di coniugare i vantaggi della gestione familiare con una maggiore protezione giuridica, evitando sovrapposizioni di responsabilità e possibili conflitti futuri.